Institute for Research on Innovation and Services for Development
Resilience - Innovation - Sustainable Development | Transparency – Organization – Meritocracy
AVVISO N. 6/2021 PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE
Il CNR – Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo ha necessità di avvalersi nell’ambito del progetto “Controllo sulle attività di pesca a seguito dell’evoluzione normativa a mezzo di un approccio integrato e con l’utilizzo di sistemi innovativi” (CUP: J61F19000170001), di un esperto per attività di ricerca e supporto nella elaborazione di indirizzi di policy in tema di digitalizzazione e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con particolare riferimento all’esigenza di contemperare l’interesse pubblico alla accessibilità delle informazioni con la tutela dei diritti di riservatezza, d’autore e di proprietà intellettuale.
Competenze richieste:
- Consolidata esperienza di studio e ricerca e/o consolidata esperienza professionale, su temi del diritto privato (IUS 01) e/o commerciale (IUS 04)
- Consolidata esperienza nelle attività di: ricostruzione e analisi critica del quadro normativo; analisi della prassi giurisprudenziale nazionale e sovranazionale; individuazione e approfondimento di incertezze interpretative e criticità applicative; elaborazione di scritti giuridici, pareri, rapporti di ricerca
Requisiti del collaboratore:
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure la Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5/05/04 e 9/07/09);
- Specializzazione post laurea in materie giuridiche, con particolare riferimento alle competenze richieste;
- Almeno 5 anni di esperienza di ricerca e/o professionale documentata, svolgendo attività coerenti con le competenze richieste;
- Conoscenza della lingua inglese
Data di scadenza: 12/04/2021
March 29th, 2021
BANDO BORSA DI STUDIO N. 2/2021
Pubblica selezione per il conferimento di n: 1 borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Ingegneria Gestionale” da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR di Napoli.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata da colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti all’Area scientifica “Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Ingegneria Gestionale” da usufruirsi presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del CNR di Napoli (città), nell’ambito del Progetto “3R4UB – The 3Rs for a sustainable use of natural resources in Ulaanbaatar”:
Tematica “La gestione sostenibile dei rifiuti sotto il profilo economico-finanziario e ambientale”. Titolo di studio (vecchio ordinamento):
- Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio
DM 509/99: 38/S
DM 270/04: LM-35 - Laurea in Ingegneria Gestionale
DM 509/99: 34/S
DM 270/04: LM-31
Scadenza: 26/04/2021
March 29th, 2021
Pubblicazione: Polymechanos ghenos – The fate of the cybernetic west, between technology and humanities

Authors: Di Trapani Giovanni, Tafuri Ranieri Maria.
March 28th, 2021
CULTURE TALKS 2021 Cultura per lo sviluppo sostenibile | Ambiente, resilienza e patrimoni

 Il 24 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, Massimo Clemente, Direttore CNR IRISS, e Gaia Daldanise, Architetto e Assegnista di Ricerca CNR IRISS, parteciperanno a “Culture Talks 2021 – Cultura per lo sviluppo sostenibile. Ambiente, resilienza e patrimoni”.
Il 24 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, Massimo Clemente, Direttore CNR IRISS, e Gaia Daldanise, Architetto e Assegnista di Ricerca CNR IRISS, parteciperanno a “Culture Talks 2021 – Cultura per lo sviluppo sostenibile. Ambiente, resilienza e patrimoni”.
Il webinar, organizzato da Trentino School of Management, si propone di indagare il rapporto tra sostenibilità futura, città e patrimonio, soffermandosi sullo sviluppo dello spazio urbano in relazione all’identità collettiva e alla fruizione attiva da parte della cittadinanza.
Infatti, sebbene la cultura non compaia esplicitamente come obiettivo specifico tra i Sustainable Development Goals (SDG) dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (2015), è innegabile che essa svolga un ruolo strategico nella costruzione di un mondo sostenibile, impattando su ben 14 dei 17 obiettivi citati nel documento.
Oltre a Massimo Clemente e Gaia Daldanise, che contribuiranno al dibattito con un intervento su “Città interetnica: lo spazio come significante per nuove pratiche aggregative”, parteciperanno all’incontro: Luca Dal Pozzolo, architetto e responsabile del settore Ricerca di Fondazione Fitzcarraldo e Alessandro Franceschini, architetto e docente a contratto presso l’Università degli Studi di Trento. A facilitare la discussione sarà Michele Lanzinger, Direttore MUSE Trento.
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online su www.tsm.tn.it
Risorse
March 23rd, 2021
European Cultural Heritage Green Paper “Putting Europe’s shared heritage at the heart of the European Green Deal”

 CLIC researchers Antonia Gravagnuolo (CNR IRISS) and Jermina Stanojev (Uppsala University) contributed as expert members to the European Cultural Heritage Green Paper, a much needed initiative on the role of cultural heritage for the implementation of the European Green Deal (EGD), coordinated by ICOMOS and Europa Nostra.
CLIC researchers Antonia Gravagnuolo (CNR IRISS) and Jermina Stanojev (Uppsala University) contributed as expert members to the European Cultural Heritage Green Paper, a much needed initiative on the role of cultural heritage for the implementation of the European Green Deal (EGD), coordinated by ICOMOS and Europa Nostra.
The European Cultural Heritage Green Paper highlights the multiple ways in which cultural heritage can contribute to the implementation of the European Green Deal, focusing on the circular economy approach in cultural heritage adaptive reuse.
In Europe, it is expected that up to 80% of buildings in use in 2050 already exist today, and currently about 35% of buildings in the EU are 50 years old or older, while 97% of the building stock is not efficient enough to comply with future carbon reduction targets (see World Green Building Council, “Bringing Embodied Carbon Upfront: Coordinated action for the building and construction sector to tackle embodied carbon”, 2019). Therefore, particularly when looking at the “renovation wave” of the EGD, “circular” cultural heritage adaptive reuse can become a fundamental strategy to renovate the historic building stock, co-generating multiple positive impacts for cities and communities. We still have much to learn from traditional building construction techniques and a high potential is available to generate jobs in this sector, hybridizing traditional knowledge and skills with the most innovative, nature-based technologies to develop safe, resilient, inclusive and sustainable cities and communities. Also, a key role of cultural landscapes in Europe is recognized in the European Cultural Heritage Green Paper, to build circular and sustainable food systems linking rural and urban communities. Much more will be discussed during the official presentation event.
Join the launch webinar of the European Cultural Heritage Green Paper on 22 March 2021 (15:00-16:30 CET).
Resources
- Information and programme about the initiative
- Registration
- Authors: Antonia Gravagnuolo (CNR IRISS), Jermina Stanojev (Uppsala University)
- Executive summary
- Full paper
- Presentation
March 19th, 2021
Call for papers dello Special Issue “Terrestrial” della rivista open access Contesti. Città, territori, progetti
E’ aperta fino al 15 aprile la call for papers dello Special Issue “Terrestrial” della rivista open access Contesti. Città, territori, progetti dell’Università di Firenze.
Curatrici: Camilla Perrone, Elena Marchigiani, Gabriella Esposito de Vita, Maddalena Rossi.
Sono benvenuti contributi interdisciplinari che evidenzino le possibili risposte dei territori (in termini di progettualità, di politiche, di approcci) alle crisi pandemiche, climatiche, ambientali, migratorie.
In particolare, intende promuovere riflessioni e contributi sulle dimensioni di incertezza che più di sempre sfidano le razionalità del progetto e della pianificazione per il futuro dei territori e che richiedono, da un lato “preparedness” (prepararsi per essere pronti), dall’altro la costruzione di un quadro orientato all’azione per promuovere in termini pro-attivi la coesione e la resilienza territoriale.
Risorse
March 17th, 2021
Call for abstracts “What’s going on in public spaces and urban cultures? Updates on current research, policy and practice” – AESOP Thematic Group Public Space and Urban Culture’s Special Session #44 at the Regions in Recovery. Building Sustainable Futures – Global E-Festival – 2/18 June 2021
Regions and cities appear to have been shaped through responses to a series of challenges and crises, including health or climate hazards, interruptions in economic growth, political upheavals or social transformations.
Urban scholars and policy-makers frequently observe and engage with public spaces as arenas which embody both the challenges and responses. The challenges have been articulated in themes such as accessibility, healthy living, democracy, justice, social movements.
Against a seemingly bleak outlook, public spaces and urban cultures also nurture optimistic responses. ‘The New Urban Agenda’, adopted by the UN-Habitat Conference, Habitat III, promotes public space as a key ingredient of ‘inclusive, connected, safe and accessible’ cities (UN Habitat, 2016).
This special session on “What’s going on in public spaces and urban cultures? Updates on current research, policy and practice” asks how public spaces can inform research, policy and practice towards creating ‘inclusive, connected, safe and accessible’ cities.
Contributions are invited, but are not limited to address one of the following topics:
- Changing typologies and roles of players and actors: multiplicity of publics and public space cultures, arenas for rebuilding participation
- Public spaces and changes: climate change, social movements, circular economy;
- Changing needs and roles: homelessness, refugees, immigrants and integration, age, gender, social, cultural, ethnic and religious considerations and urban justice;
- Questioning the global north-south divide and public space dynamics;
- Changing role of public spaces in political conflict zones;
- Changing environmental awareness: public space as a buffer zone, contribution to public health (mental and physical well-being);
- Changing intangible cultural heritage: adapting the genius loci to multiple and dynamic cultural identities;
- The impact of technological innovation on public space research and practice.
This session is organized by the AESOP Thematic Group Public Spaces and Urban Cultures, which gathers an international and interdisciplinary group of researchers and practitioners, who contribute a plurality of perspectives.
The group was established in 2010 under the umbrella of the Association of European Schools of Planning Education (AESOP).
Since then, it promotes a dialogue between practitioners, academics, governmental and non-governmental professionals, and further interest groups through virtual and physical meetings, workshops, conferences and roundtables.
Session Organisers:
- Stefania Ragozino | National Research Council of Italy, Institute for Research on Innovation and Services for Development, Naples, Italy, s.ragozino@iriss.cnr.it
- Christine Mady | Notre Dame University-Louaize, Lebanon, christine.mady@ndu.edu.lb
- Tihomir Viderman | Brandenburg University of Technology Cottbus – Senftenberg, Germany, viderman@b-tu.de
Deadline abstract submission 31th March 2021.
AESOP ExCo will cover the speaker fees (up to a maximum of 5 speakers)
Risorse
Links:
- Regions in Recovery Building Sustainable Futures – Global E-Festival
https://www.regionalstudies.org/events/rinr2021/ - 2021 Regions in Recovery Special Sessions
https://www.regionalstudies.org/news/202-ssrinr/ - AESOP Thematic Group Public Spaces and Urban Cultures
http://www.aesop-planning.eu/blogs/en_GB/urban-cultures-and-public-spaces
March 11th, 2021

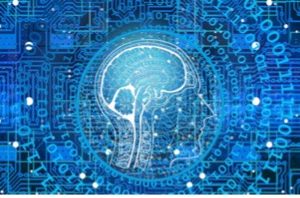
 L’intelligenza artificiale, o IA (ovvero AI per gli anglofili), si riferisce alle tecnologie capaci di analizzare il loro ambiente e di intraprendere azioni autonome rispettando valori predefiniti, simulando le abilità, il ragionamento e il comportamento umano. Nonostante le visioni apocalittiche spesso collegate, nell’immaginario collettivo, alla presenza di soggetti umanoidi nella nostra vita, da qualche decennio comincia a considerarsi l’intervento delle macchine nei processi tipicamente umani un fattore di agevolazione delle attività quotidiane, comuni e professionali, anziché un’invasione degli ultracorpi.
L’intelligenza artificiale, o IA (ovvero AI per gli anglofili), si riferisce alle tecnologie capaci di analizzare il loro ambiente e di intraprendere azioni autonome rispettando valori predefiniti, simulando le abilità, il ragionamento e il comportamento umano. Nonostante le visioni apocalittiche spesso collegate, nell’immaginario collettivo, alla presenza di soggetti umanoidi nella nostra vita, da qualche decennio comincia a considerarsi l’intervento delle macchine nei processi tipicamente umani un fattore di agevolazione delle attività quotidiane, comuni e professionali, anziché un’invasione degli ultracorpi.
 In occasione della Terza Conferenza nazionale sull’economia circolare a cui hanno partecipato, tra gli altri, con un video registrato, il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, il segretario della CGIL Maurizio Landini, l’eurodeputata Simona Bonafè, è stato presentato il
In occasione della Terza Conferenza nazionale sull’economia circolare a cui hanno partecipato, tra gli altri, con un video registrato, il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, il segretario della CGIL Maurizio Landini, l’eurodeputata Simona Bonafè, è stato presentato il 

You must be logged in to post a comment.