Institute for Research on Innovation and Services for Development
Resilience - Innovation - Sustainable Development | Transparency – Organization – Meritocracy
Home » Page 41
Cycle of seminars “Towards lifelines: territories between vulnerabilities and privileges”

 Lifelines is a DIST-POLITO funded research project that aims to observe different forms of infrastructures and their system of spaces and relations that guarantee a decent standard of livability. It promotes a cycle of online seminars.
Lifelines is a DIST-POLITO funded research project that aims to observe different forms of infrastructures and their system of spaces and relations that guarantee a decent standard of livability. It promotes a cycle of online seminars.
On 26th of March, Keller Easterling from Yale University (US) will present Medium Design; on 12th of April Matthew Gandy from Cambridge University (UK) will discuss Urban political ecology: critical reflections and future directions;and on 30th of April, Omar Jabary Salamanca from ULB (Belgium) will discuss about Weaponizing Infrastructure: Social Reproduction and the Toxic Ecologies of Settler Colonialism.
March 31st, 2021
Turismo Smart e Opportunità per le destinazioni. Un ciclo di incontri per ripartire dalle soluzioni intelligenti

 L’Agenda Digitale della regione Emilia-Romagna promuove e organizza After Futuri Digitali, il festival digitale, una manifestazione dedicata alla trasformazione digitale della società contemporanea.
L’Agenda Digitale della regione Emilia-Romagna promuove e organizza After Futuri Digitali, il festival digitale, una manifestazione dedicata alla trasformazione digitale della società contemporanea.
Si parla di ciò che viene dopo, dei futuri che ci attendono.
Quattro appuntamenti, ogni mercoledì dal 14 aprile al 5 maggio 2021, si parlerà di:
- Turismo Smart e Opportunità per le Destinazioni-Accessibilità – Coordina Maurizio Malè, Project Manager, Venetian Cluster
- Turismo Smart e Opportunità per le Destinazioni-Sostenibilità – Coordina Paolo Grigolli, Direttore Scuola di Management del Turismo, Trentino School of Management
- Turismo Smart e Opportunità per le Destinazioni-Design Experience – Coordina Edoardo Colombo, Presidente Turismo Italiae
- Turismo Smart e Opportunità per le Destinazioni-Tecnologie di realtà aumentata, realtà virtuale e intelligenza artificiale – Coordina Adele Magnelli, International Project Manager ETT – People and Technology
Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta live sul sito, il canale YouTube e la pagina Facebook di After Futuri Digitali, con la possibilità per chi segue i lavori di formulare domande e commenti ai relatori.
Media
March 31st, 2021
Corso di formazione On-line e laboratori in presenza AGENDA 2030 Costruire beni comuni. Realizzare l’Agenda 2030: Strumenti pratici per la scoperta e la gestione dei Beni Comuni

 Il Corso è organizzato da WeWorld Onlus e Regione Emilia Romagna, promosso con Fondi UE.
Il Corso è organizzato da WeWorld Onlus e Regione Emilia Romagna, promosso con Fondi UE.
Il Corso su Costruire Beni Comuni, composto da 7 webinar on-line e 2 laboratori in presenza, vuole fornire una conoscenza dei principali aspetti inerenti all’identificazione e la gestione dei beni comuni urbani, in particolare quelli emergenti. Intende fornire, quindi, una visione, il più possibile aggiornata, del dibattito in corso sul tema e strumenti operativi per promuovere ed accompagnare esperienze concrete.
Nei sette incontri on-line si affronta di volta in volta una specifica tematica legata ai beni comuni emergenti, avvalendosi della partecipazione di esperti qualificati e dell’analisi di casi studio riferiti a diverse realtà nazionali.
Due laboratori finali approfondiranno, in modo interattivo, alcuni degli argomenti trattati durante il percorso per contribuire alla definizione di risposte pratiche ed operative.
L’iscrizione al corso è gratuita. È possibile partecipare a tutte le lezioni o ai singoli eventi, on-line. Per la partecipazione ai laboratori si raccomanda di aver seguito le lezioni on-line.
March 31st, 2021
Imprese e diritti umani: un panorama normativo in evoluzione

 Marco Fasciglione è esperto di diritto internazionale e tutela internazionale dei diritti umani e ricercatore presso il CNR-IRISS, ove coordina il Progetto CO.RE, progetto che persegue l’obiettivo di analizzare e chiarire fondamenti e modalità applicative degli standard internazionali in materia di responsabilità delle imprese in tema di diritti umani ed ambiente, e in particolare quello relativo alla c.d. due diligenceaziendale sui diritti umani.
Marco Fasciglione è esperto di diritto internazionale e tutela internazionale dei diritti umani e ricercatore presso il CNR-IRISS, ove coordina il Progetto CO.RE, progetto che persegue l’obiettivo di analizzare e chiarire fondamenti e modalità applicative degli standard internazionali in materia di responsabilità delle imprese in tema di diritti umani ed ambiente, e in particolare quello relativo alla c.d. due diligenceaziendale sui diritti umani.
D. Di cosa si occupa il progetto CORE?
R. Si tratta di un settore relativamente nuovo del diritto internazionale dei diritti umani, che tuttavia ha acquisito negli ultimi 10 anni una centralità ed un’evoluzione normativa enorme. Quando ho iniziato a seguire questi temi agli inizi degli anni 2000 non c’erano standard accettati. Oggi invece le cose sono cambiate, in particolare a partire dall’adozione nel 2011 dei Principi Guida ONU su imprese e diritti umani, che hanno contribuito a definire i fondamenti del quadro normativo internazionale relativamente alla gestione dell’impatto delle attività di impresa sui diritti umani. L’obiettivo è condurre anche le imprese al rispetto dei diritti umani e contribuire allo sviluppo di una governance aziendale sostenibile: molte aziende si concentrano ancora troppo sulla performance finanziaria a breve termine rispetto agli aspetti di sostenibilità a lungo termine.
D. Dai Principi ONU ai Piani d’azione nazionali, fino al coinvolgimento europeo e ai negoziati sul trattato ONU. A che punto è il processo di responsabilizzazione delle imprese in tema di diritti umani?
R. Come anticipato, mai come in questi ultimi mesi ed anni il processo è in grande evoluzione. Dopo la loro adozione è iniziato il fondamentale processo di attuazione interna dei Principi Guida. Lo strumento utilizzato dagli Stati a tal fine è stato quello dei Piani d’azione nazionale, strumenti di supporto al policy-makingcontenenti le strategie sviluppate dagli Stati per prevenire e proteggere i diritti umani dalle violazioni che si verificano nell’ambito delle operazioni economiche delle imprese in conformità con i Principi Guida. L’Italia ha adottato il suo nel 2016, lo ha aggiornato nel 2018, e ha avviato il lavoro per l’adozione di un secondo piano di azione che succederà al primo alla scadenza (2021) di quest’ultimo.
Ma non è tutto. Il processo di convergenza verso la creazione di un level playing field, un terreno di gioco con regole uguali per tutti, con lo scopo di evitare l’esternalizzazione dei costi sociali della produzione che è all’origine di gran parte delle violazioni sui diritti umani che si verificano nell’ambito delle attività delle imprese, è proseguito poi nel 2014 con l’inizio dei negoziati sul trattato Onu su imprese e dritti umani. Dopo una fase iniziale non priva di difficoltà per lo scarso consenso da parte degli Stati che sono sedi delle grandi società multinazionali, siamo giunti nel 2020 alle negoziazioni su di una bozza che ha già l’aspetto di un trattato internazionale: la bozza contiene una lista dei diritti umani riconosciuti e ricalca i Principi Guida del 2011. Obiettivo è quello di creare un quadro giuridico comune che gli Stati aderenti dovranno applicare al fine di prevenire le violazioni dei diritti umani che avvengono nell’ambito delle operazioni economiche del settore privato. Siamo entrati in una fase di partecipazione molto attiva, che vede il coinvolgimento di parti diverse della società civile, dai sindacati alle imprese, dalle associazioni di categoria alle ONG, che non possono intervenire sul testo, ma sono comunque ascoltati.
D. E l’Unione Europea?
R. In materia ha avuto un atteggiamento ambivalente. Nell’ambito dei negoziati del trattato ONU la UE ha mantenuto una posizione iniziale attendista e poco incisiva dovuta verosimilmente al fatto che i negoziatori europei non avevano ricevuto un mandato specifico da parte delle istituzioni UE. D’altro canto negli ultimi due/tre anni a Bruxelles si sta lavorando con grande intensità sul tema e non a caso nella primavera scorsa il commissario alla Giustizia Didier Reynders ha annunciato che entro giugno 2021 verrà messa a punto la proposta della Commissione per la direttiva sulla due diligence («dovuta diligenza») delle imprese in materia di diritti umani e ambiente. Una normativa, dunque, che imporrà processi di identificazione, prevenzione, mitigazione dei rischi e responsabilità in caso di violazioni dei diritti, per le imprese europee. Anche il Parlamento Europeo si è già espresso a favore. Credo sia estremamente probabile che l’Unione avrà una sua normativa in materia in meno di un paio d’anni, mentre i tempi di un trattato multilaterale saranno molto più lunghi. Ciò che emerge in modo chiaro da questo attivismo normativo è a mio giudizio il fatto che le misure finora adottate dalle imprese, basate sulla volontarietà, sull’approccio della responsabilità sociale d’impresa, non funzionano. Dobbiamo chiederci ad esempio che tipo di contributo ha dato il movimento sulla Responsabilità sociale d’impresa nel prevenire le violazioni dei diritti umani lungo le catene di fornitura? Purtroppo, quasi nessuno. Nonostante il tema sia discusso sin dalla metà del secolo scorso, le violazioni dei diritti umani nell’ambito delle operazioni economiche delle imprese, continuano a verificarsi: tristemente noti sono i casi, in materia di diritti dei lavoratori, del crollo del Rana Plaza e dell’incendio dell’Ali Enterprises, due fabbriche una in Bangladesh l’altra in Pakistan in cui operavano imprese subappaltatrici dei grandi marchi del tessile mondiale, in cui hanno perso la vita o sono rimaste ferite centinaia di persone a causa dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza sul lavoro. E si badi: queste fabbriche avevano ricevuto la certificazione in materia sicurezza sul lavoro da enti di certificazione dei paesi occidentali!
D. Qual è la situazione in Italia?
R. Nel nostro Paese esiste una certa sensibilità in materia, anche se ancora molto deve farsi da parte del settore privato e da parte delle istituzioni nazionali. L’Italia si è data come detto un Piano d’azione su impresa e diritti umani per il periodo 2016-2021: si tratta di uno strumento politico e programmatico non vincolante che ha aperto un dialogo tra istituzioni, imprese, società civile e avviato un’opera di sensibilizzazione, conoscenza, formazione, per esempio per avvocati e giudici. Adesso il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), ha avviato il lavoro che condurrà all’adozione del nuovo piano d’azione nazionale 2021-2026. In linea con l’approccio “multistakeholder” che contraddistingue la redazione di questi strumenti, il Comitato ha avviato una consultazione pubblica: chiunque sia interessato a partecipare alla consultazione on-line, potrà farlo entro il 12 aprile 2021, utilizzando il questionario disponibile al link presente nel sito del CIDU.
Inoltre, come tutti i membri dell’Ocse, nell’ambito delle Linee guida per le imprese multinazionali, l’Italia si è dotata del Punto di contatto nazionale, che è un organismo che opera all’interno del ministero dello Sviluppo economico, e che fa da camera di mediazione/arbitrato tra vittime e imprese che hanno sede in Italia.
D. Qual è il punto di vista delle imprese in questa materia?
R. Ovviamente c’è sempre stata, e continua ad esserci, una certa resistenza all’introduzione di nuove regole. Va detto però che sempre più spesso inizia ad esserci un certo consenso in Europa e in altri continenti circa la necessità che si giunga ad un quadro giuridico armonizzato comune per tutti. A ben vedere, se si riuscisse ad intervenire sul fenomeno del forum shopping e cioè la ricerca lungo il globo delle migliori condizioni di produzione (i.e. minori costi di produzione) che si traduce inevitabilmente in peggiori condizioni di lavoro, di tutela dei diritti degli individui, di protezione dell’ambiente, ecc., tutte le imprese potrebbero competere in condizioni di vera parità, e senza sacrificare i diritti dell’individuo sull’altare del profitto. Si pensi, giusto per un esempio collegato all’attualità, allo squilibrio nei rapporti di forza che si origina nelle catene di fornitura tra aziende committenti ed i proprietari delle fabbriche situati a valle delle stesse, e che, ad esempio, durante la pandemia ha consentito alle prime di modificare unilateralmente i termini dei loro rapporti contrattuali con i fornitori, attraverso il ricorso all’eccezione di forza maggiore, e rifiutare in alcuni casi di pagare beni già prodotti. Anche in questo caso il tema è in forte evoluzione. Nel 2020 la Commissione europea ha pubblicato uno studio sui requisiti di due diligence lungo le catene di fornitura in cui la maggior parte degli stakeholder intervistati – per lo più imprese – ha affermato di aver constatato l’inefficacia dell’attuale sistema di misure volontarie. In questo senso, l’ampio campione di aziende intervistate si è dichiarato a favore di una regolamentazione europea sulla due diligence, affermando inoltre di aspettarsi numerosi benefici economici derivanti da tale obbligo. In Lussemburgo c’è un gruppo di imprese che ha già anticipato di voler sostenere la adottanda direttiva europea, lo stesso dicasi in Olanda. Ovviamente, nel Nord Europa esiste una sensibilità diversa. In Italia, anche se non mi risultano ancora imprese che si siano espresse esplicitamente a favore, si può notare un crescente interesse. Le grandi imprese si informano, chiedono formazione, cominciano a creare dipartimenti sui diritti umani. Si sarebbe portati a pensare che hanno qualcosa da farsi perdonare. In realtà, poiché le aziende sanno che c’è un consenso politico crescente su questo tema, sono consapevoli che prima o poi saranno obbligate ad adottare i modelli organizzativi interni volti a dare attuazione al dovere di due diligence anche sui diritti umani e l’ambiente (così come già avviene in altri contesti dell’azione d’impresa). Del resto sono consapevoli anche che ne avranno un ritorno: il rischio reputazionale si traduce in rischio economico. Se violano i diritti umani, se inquinano l’ambiente, si espongono a boicottaggi, campagne social, scioperi, ritardi negli investimenti, e al contenzioso legale: tutte cose che hanno un costo.
March 31st, 2021
Protocollo d’Intesa tra CNR-IRISS e 012Factory s.r.l.
Il protocollo d’intesa è volto a porre in essere iniziative congiunte tra CNR-IRISS e 012Factory per agevolare la collaborazione tra imprese leader, favorire processi di innovazione, formazione ed internazionalizzazione finalizzati alla competitività.
Strategicamente importante la collaborazione con 012Factory. Il digital innovation hub, con sede a Caserta, è un incubatore certificato di start-up innovative, che sostiene, sviluppa ed accompagna la crescita di nuove imprese ad alto potenziale innovativo, a partire dall’idea di start-up fino alla sua effettiva trasformazione in azienda innovativa attiva sul mercato.
L’impegno a fornire i servizi di accelerazione alle imprese innovative facenti parte del network dell’istituto, a coinvolgere le aziende partner per l’intercettazione della domanda di ricerca e di tecnologia costituisce un contributo sicuramente importante per le attività dell’istituto rivolte all’innovazione e allo sviluppo dei servizi.
Il protocollo è finalizzato, inoltre, ad instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti per la partecipazione ai bandi con oggetto coerente con i temi del trasferimento tecnologico e dell’innovazione.
March 31st, 2021
Protocollo d’Intesa tra CNR-IRISS e l’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus
L’Accordo è finalizzato ad instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca del CNR-IRISS e le attività dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche, di recente entrata a far parte della “Rete Faro Italia”, promossa nel 2019 dall’Ufficio di Venezia del Consiglio d’Europanell’ambito della “Convenzione sul valore del patrimonio culturale per la società” (Convenzione di Faro 2005), possano coordinarsi reciprocamente avviando un rapporto di collaborazione pluriennale per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile dell’identità storica e del circuito delle eredità culturali borboniche (materiali/immateriali) dell’Italia meridionale.
Per il raggiungimento degli obiettivi verranno sviluppate adeguate attività finalizzate a migliorare la qualità della vita delle comunità locali attraverso:
- efficienti strategie di comunicazione e promozione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione, basate anche sul coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni e imprese, a tutti i livelli;
- individuazione, tutela e gestione del patrimonio culturale e naturale di riferimento;
- sviluppo del processo di partecipazione avviato per la valorizzazione del circuito delle eredità culturali “borboniche” (materiali/immateriali) della macro-regione del Sud Italia in un’ottica di coesione e sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso il coinvolgimento attivo delle comunità territoriali e secondo il modello del distretto culturale.
Il processo prevede di mettere in relazione e connettere in maniera permanente musei, aree archeologiche, luoghi culturali e naturali, utenti, attività, filiere, prodotti, servizi e risorse distintive, attraverso un ecosistema creativo digitale di comunicazione, applicazioni e funzioni, sulla base della comune identità culturale, accrescendone l’immagine, l’attrattività e la reputazione su un piano locale, nazionale, euro-mediterraneo ed internazionale.
March 31st, 2021
Terrestrial – Call for paper della rivista Contesti Città Territori Progetti
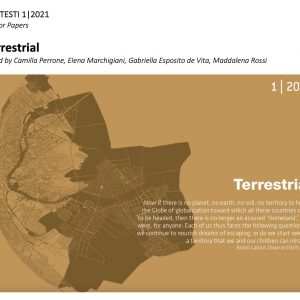
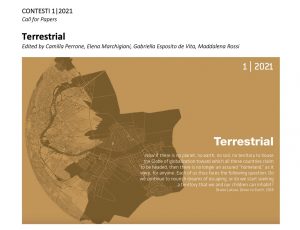 Terrestrial, la call for paper della rivista Contesti Città Territori Progetti dell’Università degli Studi di Firenze, edita da Firenze University Press, accoglie contributi interdisciplinari che evidenzino le possibili risposte dei territori (in termini di progettualità, di politiche, di approcci) alle crisi pandemiche, climatiche, ambientali, migratorie.
Terrestrial, la call for paper della rivista Contesti Città Territori Progetti dell’Università degli Studi di Firenze, edita da Firenze University Press, accoglie contributi interdisciplinari che evidenzino le possibili risposte dei territori (in termini di progettualità, di politiche, di approcci) alle crisi pandemiche, climatiche, ambientali, migratorie.
In particolare, la call invita a presentare contributi teorici, metodologici e descrittivi (casi studio, approcci, politiche territoriali) sui seguenti temi:
- Resilienza territoriale: costruzione di politiche, piani e progetti integrati
- Effetti e risposte territoriali alle crisi climatiche, migratorie, pandemiche e ambientali
- Politica ecologica territoriale e urbana
- “Preparedness” come risposta alle crisi
- Orientamento alla pianificazione territoriale strategica in contesti di incertezza
- Rafforzamento della dimensione territoriale delle politiche di settore a tutti i livelli di governance
- Nuova politica di coesione territoriale europea
March 31st, 2021
Bando: Innovare in rete

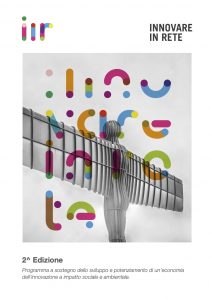 Seconda edizione del programma “Innovare in rete” che, in coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal titolo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile oltre che con gli obiettivi dei programmi New Deal e Next Generation EU della Commissione Europea, promuove e sostiene lo sviluppo e potenziamento di una economia dell’innovazione a impatto sociale e ambientale.
Seconda edizione del programma “Innovare in rete” che, in coerenza con la risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal titolo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile oltre che con gli obiettivi dei programmi New Deal e Next Generation EU della Commissione Europea, promuove e sostiene lo sviluppo e potenziamento di una economia dell’innovazione a impatto sociale e ambientale.
Il bando “Innovare in rete”, promosso da Entopan Innovation e da Banca Popolare Etica, in partnership con il Sistema Consulenziale Esperto composto da Entopan, Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Giacomo Brodolini, è un programma di accompagnamento per progetti innovativi a impatto sociale e ambientale che si rivolge a start-up, spin-off, PMI ed enti del terzo settore che abbiano già incubato o sviluppato iniziative ad elevato contenuto di innovazione sociale e tecnologica per affrontare le sfide sociali e ambientali delle città e delle comunità.
Obiettivo principale del bando è offrire gli strumenti per consentire alle giovani imprese di essere più competitive sui mercati nazionali ed internazionali ed essere in grado di affrontare i nuovi scenari post-pandemici nell’ambito dei seguenti settori:
- Economia circolare;
- Mobilità, ambiente, efficienza energetica;
- Welfare, salute e qualità della vita.
10 milioni di euro destinati a progetti di investimento del valore complessivo compreso tra 300 e 500 mila euro.
Per partecipare occorre presentare la propria proposta sulla piattaforma https://innovareinrete.entopaninnovation.it/ dal 29 marzo al 30 aprile 2021.
March 31st, 2021
Call for Paper – EFITA – Digital Agricolture Web Conference 2021

Pietro Evangelista, as a member of the Scientific Committee of European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and the Environment (EFITA), invite you to submit a paper to this international online conference.
March 30th, 2021
Call for paper – Fourth Piccola Impresa / Small Business Conference – Urbino, 3-4 December 2021
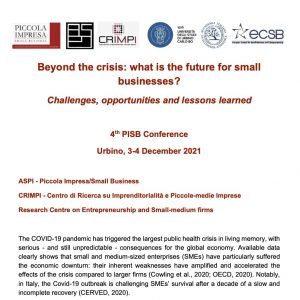
Pietro Evangelista, as a member of the Scientific Committee of 4th PI/SB Conference entitled “Beyond the crisis: what is the future for small businesses? Challenges, opportunities and lessons learned”, invite you to submit a paper to this international conference.
March 30th, 2021
CNR - National Research Council
IRISS - Institute for Research on Innovation and Services for Development
Via Guglielmo Sanfelice, 8. 80134, Napoli
T: +39 081 2470911
Email: segreteria@iriss.cnr.it
PEC: iriss@pec.cnr.it

You must be logged in to post a comment.