È stato presentato lo scorso dicembre nell’aula magna di Palazzo Gravina, sede del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il volume La Mostra d’Oltremare nella Napoli occidentale. Ricerche storiche e restauro del moderno.
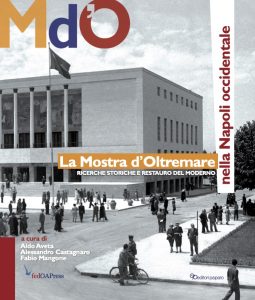 Articolato in quattro sezioni principali che documentano le ragioni e l’urgenza della ‘riscoperta’ e messa in valore di uno dei brani più significativi della Napoli contemporanea – ma anche, e inspiegabilmente, dei più a lungo ignorati dalla storiografia – il poderoso e ben documentato volume “La Mostra d’Oltremare nella Napoli occidentale. Ricerche storiche e restauro del moderno”, curato da Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, docenti del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, ripercorre le alterne vicende storiche e le scelte culturali e politiche che hanno contrassegnato l’evoluzione del complesso espositivo nel tempo, dalla sua originaria organizzazione e struttura agli sviluppi più recenti, evidenziando il patrimonio di valori, significati e simboli che lo contraddistingue per pervenire alla costruzione di un solido sistema di conoscenza, supporto indispensabile per garantirne la futura ‘rinascita’.
Articolato in quattro sezioni principali che documentano le ragioni e l’urgenza della ‘riscoperta’ e messa in valore di uno dei brani più significativi della Napoli contemporanea – ma anche, e inspiegabilmente, dei più a lungo ignorati dalla storiografia – il poderoso e ben documentato volume “La Mostra d’Oltremare nella Napoli occidentale. Ricerche storiche e restauro del moderno”, curato da Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, docenti del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, ripercorre le alterne vicende storiche e le scelte culturali e politiche che hanno contrassegnato l’evoluzione del complesso espositivo nel tempo, dalla sua originaria organizzazione e struttura agli sviluppi più recenti, evidenziando il patrimonio di valori, significati e simboli che lo contraddistingue per pervenire alla costruzione di un solido sistema di conoscenza, supporto indispensabile per garantirne la futura ‘rinascita’.
Dedicato alla figura di Benedetto Gravagnuolo – preside della Facoltà di Architettura della Federico II, nel 2012 direttore del Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro e responsabile scientifico della convenzione siglata con la Mostra d’Oltremare con la quale ebbe avvio il progetto – il volume si apre con le Presentazioni delle autorità che ne hanno avallato e sostenuto negli anni la realizzazione per proseguire con l’Introduzione a firma dei curatori in cui vengono tracciate le linee metodologiche e d’indirizzo poste alla base del complesso progetto multi scalare e multidisciplinare di ricerca.
Il ricco portfolio fotografico di Paolo De Stefano separa la parte introduttiva dalle presentazioni, rispecchiandosi idealmente nel repertorio di immagini del 1940 e nel portfolio firmato da Florian Castiglione a conclusione del volume, a sottolineare il ruolo centrale della fotografia quale formidabile strumento di ‘lettura’ e tutela del patrimonio architettonico.
Ma è nei tempi della storia che il volume trova la sua più significativa ed efficace chiave di lettura, come sottolineano le stesse titolazioni assegnate alle quattro sezioni in cui è strutturato il corpus degli scritti. È proprio la variabile tempo a contrassegnare, più d’ogni altra, il destino della Mostra: il tempo del progetto e della messa a punto (1936-’40); il tempo della distruzione e della dimenticanza (il dopoguerra); il tempo della ricostruzione e dell’auspicata rinascita (gli anni ’50); il tempo del declino e della negazione, culminato nel dopo terremoto degli anni ’80 con l’abbattimento delle Serre Botaniche di Carlo Cocchia, vero “manifesto dell’architettura razional-funzionalista a Napoli” (Castagnaro, p.162); fino ad arrivare agli interventi attuati in occasione dei Mondiali di Calcio Italia ’90 che interessarono, alterandola profondamente, l’area di piazzale Tecchio e agli anni della speranza e del progetto (1998-2005) durante i quali fu finalmente avviata una nuova visione progettuale e strategica del complesso.
Dal 2012 si è cominciato nuovamente a guardare alla Mostra come a un importante tassello nell’organizzazione funzionale della città, ricollocandola in quella dimensione urbana e territoriale che le appartiene per impostazione e per progetto e che oggi condivide con la nuova estensione politica e territoriale assegnata a Napoli città metropolitana.
I curatori del volume rintracciano sapientemente tale dimensione, facendo emergere di volta in volta i valori storico-artistici e identitari della Mostra, tenendo come orizzonte le sue molteplici vocazioni funzionali, risorsa indispensabile per riaffermare il ruolo strategico svolto, allora come oggi, dal complesso quale straordinario elemento di coesione territoriale e cerniera capace di rammagliare il quartiere Fuorigrotta a Bagnoli e all’area flegrea in una visione sistemica, territoriale e dinamica, dell’intera area occidentale della città.
Il recupero e la valorizzazione della Mostra d’Oltremare tra istanze storiche, istanze conservative e istanze progettuali non potrà che avvenire a partire dalla costruzione di un accurato e solido impianto conoscitivo che i 45 autorevoli studiosi – appartenenti prevalentemente all’Ateneo federiciano con la partecipazione di docenti dell’Università Suor Orsola Benincasa e della Università della Campania Luigi Vanvitelli – delineano con rigore di metodo e acume critico, attraverso analisi puntuali e approfondimenti documentali in molti casi inediti, portando in primo piano il molteplice patrimonio materiale e immateriale della Mostra e l’esigenza di prevederne la conservazione e la tutela a partire dal restauro dei suoi patrimoni fragili.
Il tutto nella lucida consapevolezza che solo tale sistema di conoscenza – storica, artistica, contestuale, urbana, territoriale, architettonica, materica, gestionale – potrà fornire lo strumento indispensabile per progettare – come si afferma nell’Introduzione – “destinazioni future degne non solo del valore architettonico del complesso, ma anche delle potenzialità funzionali che tale unicum può dispiegare rispetto al più vasto comparto urbano” (p.39).
Risorse


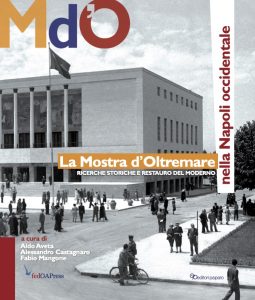 Articolato in quattro sezioni principali che documentano le ragioni e l’urgenza della ‘riscoperta’ e messa in valore di uno dei brani più significativi della Napoli contemporanea – ma anche, e inspiegabilmente, dei più a lungo ignorati dalla storiografia – il poderoso e ben documentato volume “La Mostra d’Oltremare nella Napoli occidentale. Ricerche storiche e restauro del moderno”, curato da Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, docenti del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, ripercorre le alterne vicende storiche e le scelte culturali e politiche che hanno contrassegnato l’evoluzione del complesso espositivo nel tempo, dalla sua originaria organizzazione e struttura agli sviluppi più recenti, evidenziando il patrimonio di valori, significati e simboli che lo contraddistingue per pervenire alla costruzione di un solido sistema di conoscenza, supporto indispensabile per garantirne la futura ‘rinascita’.
Articolato in quattro sezioni principali che documentano le ragioni e l’urgenza della ‘riscoperta’ e messa in valore di uno dei brani più significativi della Napoli contemporanea – ma anche, e inspiegabilmente, dei più a lungo ignorati dalla storiografia – il poderoso e ben documentato volume “La Mostra d’Oltremare nella Napoli occidentale. Ricerche storiche e restauro del moderno”, curato da Aldo Aveta, Alessandro Castagnaro e Fabio Mangone, docenti del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, ripercorre le alterne vicende storiche e le scelte culturali e politiche che hanno contrassegnato l’evoluzione del complesso espositivo nel tempo, dalla sua originaria organizzazione e struttura agli sviluppi più recenti, evidenziando il patrimonio di valori, significati e simboli che lo contraddistingue per pervenire alla costruzione di un solido sistema di conoscenza, supporto indispensabile per garantirne la futura ‘rinascita’.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.