
 In the frame of the EU Green Week 2021, the European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), one of Be.CULTOUR partners, hosted an online Partner Event focused on sustainable practices towards zero-pollution tourism.
In the frame of the EU Green Week 2021, the European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), one of Be.CULTOUR partners, hosted an online Partner Event focused on sustainable practices towards zero-pollution tourism.
On Monday 7 June 2021 the event was organised by the ERRIN Working Group on Cultural Heritage & Tourism in the frame of the EU Green Week 2021 – Zero pollution for healthier people and planet. At the event, the Be.CULTOUR project was presented by the coordinator Antonia Gravagnuolo, Researcher at CNR- IRISS, highlighting how it is now crucial to move beyond tourism through a longer-term human-centred development perspective, enhancing cultural heritage and landscape values. By targeting deprived remote, peripheral or deindustrialised areas and cultural landscapes, as well as over-exploited areas, H2020 Be.CULTOUR project will co-develop long-term heritage-led development activities in the areas involved and enhance inclusive economic growth, communities’ well-being and resilience, nature regeneration, and effective cooperation at cross border, regional and local level. Finally, bringing circular economy into cultural tourism will boost the creation of new sustainable and slow mobility systems, the reduction of natural resources consumption, the regeneration of natural, cultural and human capital, the valorisation and adaptive reuse of less known or even abandoned heritage sites and the preservation of a healthy and beautiful environment.
Three ERRIN members were also selected to share their experience implementing tourism practices focused on natural preservation, sustainable mobility, and digital uptake in tourism with a focus on culture. Janie Neumann, Sustainable Tourism Manager at VisitScotland, Vanessa Glindmeier, Business Support Officer at Historic Environment Scotland and Claire Munro, Communications Workstream Lead at Zero Waste Scotland, highlighted how Scotland’s tourism industry can deliver on Scotland’s national commitment to Net Zero Green House Gas emissions by 2045, highlighting examples of activities that look to reduce various kinds of pollution through actively engaging visitors as well as businesses and deliver on Scotland’s NetZero commitments.
Other interventions related to sustainable tourism were presented: Aivar Ruukel, (EDEN) Board of Administrators – representing the Sooma National Park, recipient of the EDEN award in 2007 in the category Tourism and protected areas; Ward Segers, Project Coordinator at Visit Limburg, with Flemish experience of building 2000 km of cycling paths that turned Limburg into a well-known cycling destination; Ramón Lasaosa, Councillor for Culture and Festivities of the Huesca City Council presented local practices linking natural heritage preservation and tourism activities.
June 7th, 2021
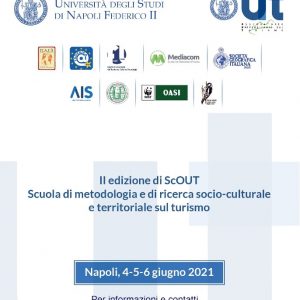
 The Observatory on Tourism of the University of Naples Federico II – OUT – organized the second edition of “ScOUT”, School of Sociology of Tourism, with the theme “Eco-tourism and socio-territorial research methods on tourism”. The event proposed 3 days (4-6 June 2021) of training and socio-territorial research on the relationship between tourism and biodiversity, opened with the International Conference “Ecotourism: travellers, local communities, territories, experiences in the space of new society”.
The Observatory on Tourism of the University of Naples Federico II – OUT – organized the second edition of “ScOUT”, School of Sociology of Tourism, with the theme “Eco-tourism and socio-territorial research methods on tourism”. The event proposed 3 days (4-6 June 2021) of training and socio-territorial research on the relationship between tourism and biodiversity, opened with the International Conference “Ecotourism: travellers, local communities, territories, experiences in the space of new society”.
The focus of the event is the importance of protecting natural environments for the preservation of biodiversity. Primary importance for nature conservation is the relationship of biodiversity with tourism. In the last decade, travel destinations have become more diversified and visitors increasingly demand ecotourism through trips to enjoy activities in direct contact with natural, wild and unhumanised environments.
Research methods, exchange, integration, diversity, eco-sustainable development, the cultural and economic progress of human societies, respect for fundamental natural rights, freedom and dignity of every human being, while protecting and making reasonable use of natural resources: this is the perspective from which the relationship between biodiversity and tourism can be interpreted. This theme is even more relevant in view of the recovery of tourism after the COVID-19 pandemic: because the restart, as stressed by many, must be an opportunity to rethink tourism with a different focus on long-term sustainability, full respect for the environment, the authenticity of places and the rediscovery of traditions.
The first of three days, the coordinator of the European project Be.CULTOUR, researcher Antonia Gravagnuolo from the CNR-IRISS research institute, contributed by referring the themes of the project, highlighting the importance to move beyond tourism through a longer-term human-centred development perspective, enhancing cultural heritage and landscape values, promoting an understanding of cultural tourism towards one that puts humans and circular economy models at its centre, paying attention to nature, communities and cultural diversity. In particular, Gravagnuolo explained how the circular economy model based on a human-centred approach can stimulate sustainable growth in terms of tourism, also in order to cope with the effects of the Covid-19 pandemic on the territories. This is possible through the passage from a dissipative tourism to a regenerative one which, among other things, reuses in adaptive terms the natural and cultural capital. The project aims to stimulate communities to cooperate towards a common goal by identifying appropriate strategies that take into account also local specificities.
The event was held in online mode for the International Conference and social research methodology workshop, while the final event on 6th June 2021 provided a scientific visit to the WWF Oasis “Cratere degli Astroni” Italian Nature Reserve, with the aim of providing the elements for understanding the planning, development and management of an ecotourism activity. The initiative aimed to show how ecotourism activities can be carried out in urban and peri-urban environments, bringing users closer to urban biodiversity.
More info
June 6th, 2021
 Il CNR-IRISS con la firma dell’accordo “Per la valorizzazione e lo sviluppo dell’identità culturale di specifici contesti territoriali e la costituzione di distretti culturali” ha formalizzato e avviato un rapporto di collaborazione di particolare rilevanza scientifica al fine di sviluppare una ricerca interattiva e multidisciplinare nell’ambito dei distretti culturali, volta a favorire lo sviluppo economico del territorio.
Il CNR-IRISS con la firma dell’accordo “Per la valorizzazione e lo sviluppo dell’identità culturale di specifici contesti territoriali e la costituzione di distretti culturali” ha formalizzato e avviato un rapporto di collaborazione di particolare rilevanza scientifica al fine di sviluppare una ricerca interattiva e multidisciplinare nell’ambito dei distretti culturali, volta a favorire lo sviluppo economico del territorio.
I partner dell’accordo sono:
il Museo Archeologico di Napoli, il Centro Universitario Europeo Beni Culturali, il Centro Europeo di Studi sul Mito e sul Simbolo dell’Università di Messina, il Centro di Studi sulla Simbolica Giuridica, la Fondazione “Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia”, l’Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei e il Comitato per la valorizzazione della cultura classica greca e latina, come patrimonio immateriale bene dell’umanità, e per la istituzione dei distretti culturali europei.
È prevista, inoltre, a breve, l’adesione da parte dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, di Pompei e dei Campi Flegrei.
L’obiettivo principale del programma di azione è la costituzione di distretti culturali europei che abbiano come matrice culturale comune la cultura classica latina e greca, uniti tra loro in un percorso ideale che parte dalla Sicilia fino al nord dell’Italia, verso Gorizia.
La ricerca partirà dalla definizione di Distretto Culturale Europeo, proseguirà con l’identificazione di luoghi che abbiano una medesima matrice culturale europea e proporrà strumenti giuridici tesi alla loro regolamentazione.
Sono previste, successivamente, azioni di valorizzazione e sviluppo dell’identità culturale dei contesti territoriali identificati, realizzazione di reti di istituzioni e operatori sociali, di comunità politici ed economici per la mappatura delle risorse locali, legati all’ambiente e alla cultura, che siano sostenibili imprenditorialmente sulla base di una “filiera culturale”.
A conclusione, l’integrazione dei distretti identificati in un sistema più ampio di cooperazione di comunità e operatori all’interno della matrice culturale comune.
Azioni di accompagnamento alle attività, saranno la promozione di un fondo europeo della cultura per lo sviluppo di attività imprenditoriali a favore dei giovani e la promozione della giornata mondiale della cultura classica latina ed europea.
Altre informazioni:
May 21st, 2021

 Il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione COTEC proseguirà il prossimo 26 maggio con un nuovo workshop online gratuito.
Il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione COTEC proseguirà il prossimo 26 maggio con un nuovo workshop online gratuito.
Dopo aver affrontato nei primi due appuntamenti le problematiche connesse alla tutela della privacy e della riservatezza dei dati personali in un ambiente caratterizzato dall’utilizzo di applicazioni di Intelligenza Artificiale e quelle relative all’impatto di questa nuova tecnologia sul mondo del lavoro, l’appuntamento di maggio proverà a spiegare “Perché l’Intelligenza Artificiale non è solo per le grandi aziende: la partita delle PMI”.
In ogni settore produttivo si trovano applicazioni estremamente interessanti delle nuove tecnologie di IA, ma, sebbene il processo di diffusione di queste nuove tecnologie stia procedendo costantemente, da più parti ancora esiste la convinzione che si tratti di applicazioni utili e applicabili soprattutto dalle grandi aziende.
Nel corso del III workshop, ci si propone di riflettere e discutere, insieme ad esperti di Intelligenza Artificiale e rappresentanti del mondo delle PMI, su quale sia realmente la situazione al momento, quali le esigenze delle PMI che potrebbero essere soddisfatte più efficacemente grazie a queste tecnologie e quali i vantaggi che ne potrebbero derivare. Si cercherà anche di comprendere quali siano le criticità da superare e le misure da adottare per accelerare l’adozione dell’IA nelle aziende.
Il ciclo di incontri fa parte del progetto, avviato nel dicembre dello scorso anno con il lancio del corso di formazione online “Elements of AI – Elementi di Intelligenza Artificiale”, coordinato dalla Fondazione COTEC e realizzato con la partnership accademica dell’Università Roma Tre e il supporto, nell’ambito dell’iniziativa Repubblica Digitale, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’obiettivo è diffondere una cultura dell’innovazione che promuova l’utilizzo delle tecnologie IA approfondendone ed evidenziandone potenzialità e vantaggi per le imprese e nella vita di tutti i giorni.
Data evento: 26 maggio 2021
Per registrarsi, seguire il workshop e avere maggiori informazioni: https://cotec.it/eventi-cotec/
May 21st, 2021

 Arrivato alla sua quinta edizione, il Festival promosso dall’Asvis si svolgerà nuovamente in tutta Italia e in rete.
Arrivato alla sua quinta edizione, il Festival promosso dall’Asvis si svolgerà nuovamente in tutta Italia e in rete.
Già nell’edizione del 2020, il Festival ha testimoniato la volontà di un’ampia fascia della società di mobilitarsi per costruire un futuro migliore con gli oltre 800 eventi realizzati su tutto il territorio.
A segnare le tappe di un ideale percorso di avvicinamento alla manifestazione, nei mesi di maggio e giugno 2021 l’Asvis riproporrà anche gli “Asvis Live”, gli appuntamenti di alto livello pensati per sollecitare e favorire una riflessione sulle politiche e sulle azioni da intraprendere per potenziare la resilienza trasformativa del sistema socio-economico italiano nella direzione tracciata dall’Agenda 2030.
Ad arricchire gli eventi contribuirà anche FUTURA Network, la rete promossa dall’Asvis per promuovere il dibattito sulle scelte necessarie oggi per costruire un futuro sostenibile.
Il Festival è aperto a tutti, qualsiasi attore della società civile è invitato a partecipare!
Presto sarà disponibile il nuovo sito del Festival dove sarà possibile candidare il proprio evento contribuendo attivamente alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
Data evento:
Dal 28 settembre al 14 ottobre 2021.
Disponibile su:
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9533/torna-il-festival-dello-sviluppo-sostenibile-ecco-le-date-della-quinta-edizione
https://asvis.it/asvis-live-i-risultati/
May 21st, 2021
« Previous Page —
Next Page »
 Il CNR-IRISS con la firma dell’accordo “Per la valorizzazione e lo sviluppo dell’identità culturale di specifici contesti territoriali e la costituzione di distretti culturali” ha formalizzato e avviato un rapporto di collaborazione di particolare rilevanza scientifica al fine di sviluppare una ricerca interattiva e multidisciplinare nell’ambito dei distretti culturali, volta a favorire lo sviluppo economico del territorio.
Il CNR-IRISS con la firma dell’accordo “Per la valorizzazione e lo sviluppo dell’identità culturale di specifici contesti territoriali e la costituzione di distretti culturali” ha formalizzato e avviato un rapporto di collaborazione di particolare rilevanza scientifica al fine di sviluppare una ricerca interattiva e multidisciplinare nell’ambito dei distretti culturali, volta a favorire lo sviluppo economico del territorio.

 In the frame of the EU Green Week 2021, the
In the frame of the EU Green Week 2021, the 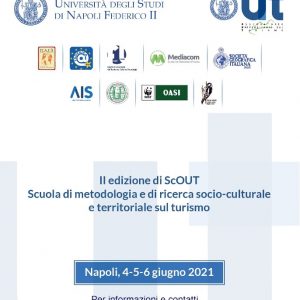
 The Observatory on Tourism of the University of Naples Federico II – OUT – organized the second edition of “ScOUT”, School of Sociology of Tourism, with the theme “Eco-tourism and socio-territorial research methods on tourism”. The event proposed 3 days (4-6 June 2021) of training and socio-territorial research on the relationship between tourism and biodiversity, opened with the International Conference “
The Observatory on Tourism of the University of Naples Federico II – OUT – organized the second edition of “ScOUT”, School of Sociology of Tourism, with the theme “Eco-tourism and socio-territorial research methods on tourism”. The event proposed 3 days (4-6 June 2021) of training and socio-territorial research on the relationship between tourism and biodiversity, opened with the International Conference “
 Il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione COTEC proseguirà il prossimo 26 maggio con un nuovo workshop online gratuito.
Il ciclo di incontri organizzato dalla Fondazione COTEC proseguirà il prossimo 26 maggio con un nuovo workshop online gratuito.
 Arrivato alla sua quinta edizione, il Festival promosso dall’Asvis si svolgerà nuovamente in tutta Italia e in rete.
Arrivato alla sua quinta edizione, il Festival promosso dall’Asvis si svolgerà nuovamente in tutta Italia e in rete.
You must be logged in to post a comment.