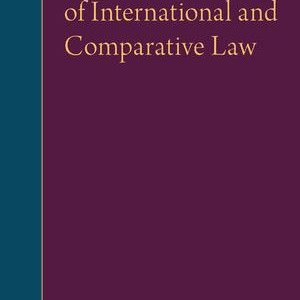
 International law and comparative law are increasingly intertwined, but are rarely studied together. The International Review of International and Comparative Law(IRIC) not only fills this gap, but also encourages the use of comparative law methodology in the investigation of international law. The Review offers an authoritative forum for debate on all subjects related to public and private international law, comparative law and European law.
International law and comparative law are increasingly intertwined, but are rarely studied together. The International Review of International and Comparative Law(IRIC) not only fills this gap, but also encourages the use of comparative law methodology in the investigation of international law. The Review offers an authoritative forum for debate on all subjects related to public and private international law, comparative law and European law.
CNR-IRISS is one of the Institutional partners of the IRIC together with the Italian branch of the International Law Association. The Review is edited open access by Brill. Prof. Fulvio Maria Palombino (Associate to the Institute) is among the Editors-in-Chiefs, together with Prof. Andrea de Guttry and Prof. Giuseppe Martinico, both from Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. Dr Giovanni Carlo Bruno (Senior Researcher of the Institute) is the Book Review Editor.
The Review welcomes contributions from legal scholars worldwide, but encourages submissions from scholars working and/or educated in Italy in particular. It actively seeks to increase the global impact of Italian doctrinal approaches to international and comparative law, which chime with the approach envisaged, and so enable the vibrant debate ongoing in Italian scholarship to reach an international audience and be enriched by it.
For all the information, and to submit articles
October 15th, 2021
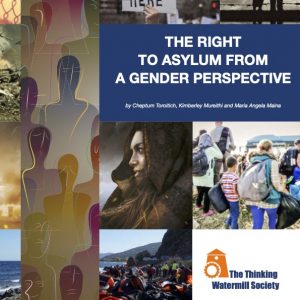
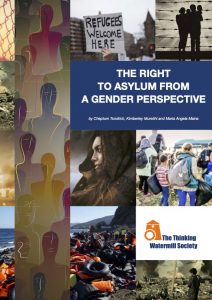 Research studies by the United Nations High Commissioner for Refugees show that there are 79.5 million forcibly displaced persons worldwide. It has come to our attention, at The Thinking Watermill Society, that although women and girls consist of half the population of refugees, they are still considered as a “minority” and a “vulnerable group”. This is not due to their number but, rather, to the systemic discrimination and subordination of their status.
Research studies by the United Nations High Commissioner for Refugees show that there are 79.5 million forcibly displaced persons worldwide. It has come to our attention, at The Thinking Watermill Society, that although women and girls consist of half the population of refugees, they are still considered as a “minority” and a “vulnerable group”. This is not due to their number but, rather, to the systemic discrimination and subordination of their status.
Hence, our research focuses on illustrating to our readers the need for gender as a protected social group in the asylum determination process, delineated within the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.
We presented our project and its relevant publication report during a meeting and webinar that took place on 14 October 2021, at the premises of Pavia e Ansaldo law firm in Rome, with the cooperation of The Thinking Watermill Society. Ms. Caterina Luciani, partner of Pavia e Ansaldo and president of The Thinking Watermill Society introduced the event and we had the honor to have Rt. Hon. Ms. Patricia Scotland, The Commonwealth Secretary General, to present the keynote speech.
Following our presentation, a roundtable of experts took place, moderated by Mr. Fulvio Maria Palombino (Professor of international law at the University of Naples, Federico II, CNR-IRISS Associate, and of-counsel at Pavia e Ansaldo law firm).
The experts that participated to the roundtable were: Mr. Giovanni Carlo Bruno (Senior researcher of international law at the CNR in Naples) Mr. Luis Gabriel Franceschi (Senior director of Governance & Peace at The Commonwealth in London, as well as professor at the Strathmore University of Nairobi, Kenya), Mr. Allan Mukuki (Director of International Partnerships at the Strathmore University of Nairobi, Kenya) and Ms. Chiara Scipioni (RSD -Refugee Status Determination- Associate, UNHCR in Rome).
Pavia e Ansaldo law firm, thanks to the international project carried out, received the sustainability award on 11 November 2021, by LC Publishing Group.
Download the unabridged version of the Study
October 14th, 2021
« Previous Page —
Next Page »

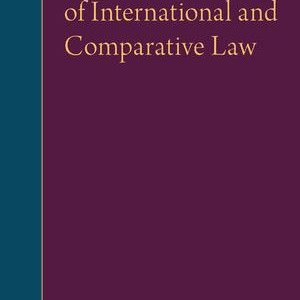
 International law and comparative law are increasingly intertwined, but are rarely studied together.
International law and comparative law are increasingly intertwined, but are rarely studied together. 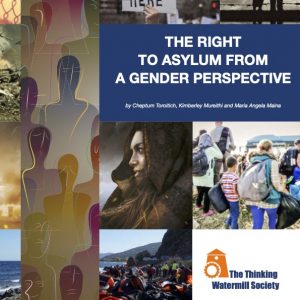
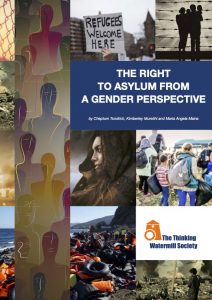 Research studies by the United Nations High Commissioner for Refugees show that there are 79.5 million forcibly displaced persons worldwide. It has come to our attention, at
Research studies by the United Nations High Commissioner for Refugees show that there are 79.5 million forcibly displaced persons worldwide. It has come to our attention, at
You must be logged in to post a comment.